Nessun prodotto
Categorie
- Gli Eccentrici
- Gli Eccentrici illustrati
- La battaglia dei libri
- Lontani da qui
- Incroci
- l'acuto
- Caribe
- La biblioteca di Lovecraft
- tReMa
- Hispánica
- Nastri d'argento
- Pagine Inattuali
- Territorio di incontro
- Nembrot
- Los juguetes rabiosos
- Lettera zero
- Narrativa
- Saggistica
- Università
- E book e DVD
- Mondo ispanico
- Umane società
Le armonie del vento, Eduardo L. Holmberg
Published : 16/03/2020 12:56:29
Categories : Letture
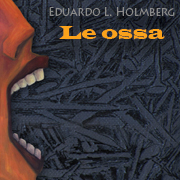
Tornavo da un viaggio lungo e faticoso e nella confusione dei primi momenti, tra gli abbracci della famiglia, le attenzioni riservate al bagaglio e la gioia di ritrovarmi nuovamente a casa, sentii rinascere in me un’allegria che mi era impossibile provare contemplando le pianure, le montagne, i boschi e i fiumi della mia terra, così ricca e bella ma anche, per effetto della sua stessa bellezza, così tirannica e dominatrice, una terra che mi avrebbe trasformato in una specie di vagabondo, in un beduino, se non fosse stato per il desiderio del cuore e per il fascino vertiginoso di una città in cui si respira un’atmosfera intellettuale e imprescindibile.
Allo scroscio dei torrenti sostituivo il tumulto dei grandi centri urbani, al profumo dei boschi il fumo di 40.000 cucine, al poncho il soprabito, alle cime innevate dei monti i capitelli corinzi, allo spiedo la griglia, al coltello da sopravvivenza le posate, alla frusta la stilografica.
Le prime domande ricevono in risposta la promessa di un resoconto dettagliato di quel che di solito non si scrive. Qui c’è tutta la corrispondenza. L’itinerario è stato seguito, lega dopo lega, via telegrafo e sulla mappa; e le lacune causate dal deserto verranno colmate più tardi dagli appunti presi durante il viaggio.
Ma procediamo con ordine. Portiamo al riparo il materiale raccolto, se non altro per evitare che una pioggia inattesa, penetrando nelle casse, possa danneggiarlo. Ecco fatto. E dopo una minuziosissima pulizia personale, che inizia dal barbiere e prosegue nel bagno, ci mettiamo a tavola, lasciando che ognuno dia libero sfogo alla sua curiosità.
Segue una sfilza di domande e risposte da cui emerge il desiderio di conoscere i tesori raccolti in terre lontane. Si aprono le casse. All’apparire di una farfalla dalle ali magnifiche, si leva un coro di meraviglia, mentre il piumaggio sfavillante di un colibrì suscita blasfeme esclamazioni di lode da parte delle donne che vorrebbero servirsene per abbellire le loro acconciature.
Qui ci sono le pietre, lì gli erbari.
«È un serpente a sonagli?».
«Ma che bella rana!».
«E questo, che pesce è?».
«Ci sono anche delle ossa umane!».
«E questi vasi?».
Amici e parenti apprendono la notizia del nostro arrivo e si uniscono alla folla dei curiosi. I compagni, mutati in volto, già sbarbati e ormai dediti alle consuete attività urbane, assistono alla rimozione della tovaglia, un arredo che mancava nelle cene nei boschi.
Tutti parlano, tutti domandano, tutti rispondono; sembra che l’animazione della scena non debba avere mai fine.
Una mano infantile e vivace solleva un cranio e lo mostra ai presenti. Se ne impossessano, lo scrutano, lo esaminano e dichiarano che appartiene a una razza indigena e pura.
«A proposito,» dice Alberto «ho qualcosa che ti potrebbe essere utile».
«Di che si tratta?».
«A casa di una famiglia di mia conoscenza ha vissuto, qualche tempo fa, uno studente di medicina che ha lasciato un sacco con delle ossa. Non sanno cosa farne da quando lui è andato via. Lo vuoi?».
«Mandamelo, di certo potrà servire a qualche studente».
«Te lo farò avere domani».
«Dove abitano i tuoi conoscenti?».
«Calle Tucuman numero…».
«Sei sicuro che siano ossa da studio?».
«Direi di sì».
«E lo studente, lo hai conosciuto?».
«Io no, ma la famiglia sì».
«Non sono ossa che potrebbero interessare alla polizia, vero?».
«Non dirlo nemmeno per scherzo!».
«Certo, certo, ma è sempre meglio essere sicuri».
Ho la sensazione che finora il lettore non abbia trovato alcun motivo per interessarsi al disordinato prologo che precede queste righe; con ogni probabilità è tentato di abbandonare una lettura che sin dal principio gli ha offerto solo una successione di fatti privati e ben pochi spunti stimolanti.
Si trova tuttavia in errore, ed è verosimile che, giudicando con imparzialità e buon senso, arrivi a riconoscere che l’autore dovesse avere qualche buona ragione per offrirgli una matassa tanto ingarbugliata invece di un calice trasparente e traboccante di liquore forte.
Se avrà la bontà di proseguire con me, nutro la speranza di fargli cambiare opinione, e, se mi perdonerà certi riferimenti a fatti personali, forse finirà per appassionarsi, com’è successo a me, alla singolare storia che sto per raccontare. Allora si renderà conto che le farfalle e i colibrì non hanno alcun ruolo nella vicenda e sono soltanto un ornamento che non guasta, proprio come un neo malizioso accanto a una bocca a confettino.
Ero, dunque, di ritorno da un viaggio.
Il giorno successivo ricevetti da Alberto una lettera che mi annunciava l’invio del sacco con le ossa; e, siccome la lettera accompagnava il sacco, le due cose giunsero in mio possesso contemporaneamente.
Trattandosi di ossa umane, di proprietà di uno studente e per di più arrivate mentre ero intento a sistemare il materiale raccolto e i manoscritti del viaggio per potermi poi dedicare al lavoro teorico, non suscitarono in me grande interesse; così riposi il sacco, senza aprirlo, in un angolo dello studio e la lettera in un cassetto della scrivania.
Per alcune settimane studiai e scrissi con entusiasmo. Quasi tutto il materiale era stato affidato alle mani di sapienti specialisti, io mi occupavo della parte di lavoro che mi era toccata, e la stesura dei manoscritti procedeva.
Talvolta, a causa delle manipolazioni microscopiche o per la necessità di cambiare posizione dopo essere rimasto a scrivere per due o tre ore, alzavo la testa e posavo lo sguardo sul sacco nell’angolo, ma lo facevo con indifferenza, senza che questo suscitasse in me altro che il ricordo della sua provenienza.
Non sono superstizioso, anche se a volte – lo dico per compiacere gli omeopati –, quando mangio rape o legumi che contengono zolfo, si risveglia nel mio cervello una strana idealità, simile per certi versi al misticismo, e mi balza nella memoria, come una lepre fosforescente, una strofa di Echeverría:
Le armonie del vento
Dicono al pensiero più di quanto
Filosofia pretende
In gara oziosa
Di insegnare altezzosa
Dal rumore del vento non ho mai imparato niente, ma è indubbio che la fantasia si compiaccia nel modellare immagini lievi e graziose, risvegliate da una musica tanto vaga quanto intraducibile.
A ogni modo è una forma di misticismo che non ha nulla di ostile.
Quando s’impadronisce dell’animo mentre scrivo, è maggiore il piacere che provo nel pensare in castigliano; leggo ad alta voce quello che sta nascendo sulla carta e mi suona più dolce, mi sembra che le figure siano più delicate, che l’immaginazione se ne vada errando come in una nube di creature eteree, di fate o di silfidi immerse in un ambiente di trasparenze iridescenti.
Il vento gemeva quindi alla finestra, e il suo gradevole canto accompagnava, per così dire, la descrizione di una grotta che stavo elaborando e che richiedeva solo la severità del geologo, non le fantasticherie di un poeta. Non riuscivo tuttavia a scrivere con la dovuta serietà e di tanto in tanto, senza che lo volessi, una frase sontuosa mandava in frantumi il complesso delle rocce rigide. Iniziò allora una lotta tra le forze della ragione, della volontà e del lirismo, e capii che il rigore scientifico mi aveva abbandonato.
Posai la penna e accesi una sigaretta.
Mentre le nuvole azzurrine mi danzavano intorno, chiusi gli occhi e rimasi ad ascoltare le “armonie del vento”.
D’improvviso si udì, come sempre inatteso, il grido stridulo di una civetta, che mi costrinse a riaprire gli occhi. Sopra il sacco con le ossa vidi l’immagine sfuggente del rapace; senza dubbio una semplice coincidenza, nient’altro che una nuvola di fumo che si era sovrapposta alla proiezione esterna della forma mentale dell’uccello notturno, evocata improvvisamente dal grido.
Non poteva essere altrimenti, dato che sul sacco non c’era assolutamente nulla.
Avrei voluto rimettermi a scrivere ma non ci riuscii.
Non trovavo le parole giuste, né giri di frase che suonassero naturali, e il mio sguardo si posava continuamente sul sacco.
Così raccolsi le carte e cercai, nei limiti del possibile, di sgomberare la scrivania; poi presi il sacco, l’aprii e sistemai le ossa sul piano. Quando le ebbi tirate fuori tutte, le ricomposi secondo natura e cominciai a studiarle metodicamente.
Era lo scheletro di un uomo giovane, di ventitré o ventiquattro anni, di struttura esile, alto circa 1,75, sano, con denti perfetti e un cranio armonioso nel quale un frenologo avrebbe riconosciuto, oltre alla manifestazione ossea di una intelligenza equilibrata e superiore, le protuberanze della venerazione, della benevolenza, della distruttività e della prudenza.
Non posso dire di uno scheletro umano ciò che ho detto del rumore del vento, perché ha insegnato molto a me e moltissimo ad altri più intelligenti di me; tuttavia sono con-vinto che ci sia anche chi ha imparato meno e persino chi non ha imparato nulla.
Mancava un solo osso, la quarta costola sinistra, una di quelle che si trovano davanti al cuore. Questa banale circostanza mi fece venire in mente molte cose che avevano di ragionevole solo la vaghezza inaccessibile della possibilità.
Incrociai le braccia e mi misi a riflettere su ciò che si poteva dedurre da un esame superficiale; provai a immaginare chi potesse essere quel povero giovane, esile e intelligente, morto nel fiore degli anni e che per un’insondabile fatalità aveva lasciato il suo scheletro alla scienza, proprio lui che per la struttura del cranio sembrava destinato a brillare nel mondo intellettuale.
Non sono superstizioso, né completamente egoista.
Provai una sensazione molto precisa, una sorta di afflizione, mentre riflettevo su alcune cose, soprattutto sull’ingiustizia della sorte che uccide un uomo dal cranio così bello e probabilmente così pieno di cervello superiore e lascia vivi tanti crani vuoti.
Così pensando, notai d’un tratto che dalla finestra giungeva di nuovo la musica del vento, mentre attraverso la porta filtravano allegri i raggi di un sole invernale.
Traduzione di Agnese Guerra



